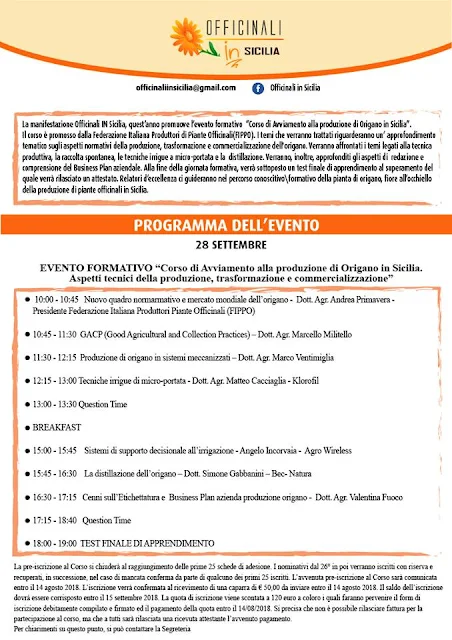Fino a non molti decenni fa esistevano in Italia intere aree rurali. Non è che non esistano più, è solo che queste aree hanno preso due derive: in alcune, quelle più fertili e meglio collegate con la rete stradale, è piombata l’agricoltura industrializzata, (in crisi perenne) che si è buttata a capofitto su terreni da coltivare con macchine e pesticidi; negli altri casi la popolazione ha scelto di elevare il proprio livello di vita e di abbandonare una vita e un’economia di sussistenza, di aree arretrate del sud, e di emigrare nelle città.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti è che in Italia ci sono da un lato sistemi urbani che stanno esplodendo, città infinite (si pensi alla cosiddetta Megalopoli Padana, che va da Milano a Venezia senza soluzione di continuità), contigue a terreni dove l’agricoltura a livello industriale la fa da padrona, e dall’altro lato esistono interi pezzi di Paese che nei casi migliori vivono o grazie alla diffusione di agriturismi e bed and breakfast, oppure vivono un costante decremento demografico e vengono tenuti in piedi da pochi anziani.
Aspetti negativi su un piatto della bilancia che venivano equilibrati, dall’altro, da valori contadini, tradizioni enogastronomiche e artigianali tramandate di generazione in generazione, ma soprattutto la realizzazione di un tipo di società fondata sulla solidarietà reciproca, valori che oggi si sono quasi consumati dopo decenni di industrializzazione e di sradicamento degli individui dalla terra.
Ma quella vita di sussistenza, che ha dato da mangiare a tutti nei secoli, era in realtà una magnifica espressione della società contadina che, tuttavia, comportava tanti rischi, come la mortalità infantile, l’alto livello di diffusione di malattie, la malnutrizione. Tutti aspetti inevitabili se quella vita era il massimo a cui la gran parte della popolazione poteva realisticamente aspirare.
La convinzione dominante che l’approvvigionamento alimentare potesse essere affidato al mercato globale ha, tuttavia, subìto un forte ridimensionamento negli ultimi anni di crisi, che, se non altro, ha avuto il “merito” di portare molti a rivalutare quei valori e quelle tradizioni troppo velocemente abbandonati.Così si arriva al punto del discorso l'avvio di una campagna popolare finalizzata all’approvazione di “una legge che riconosca l’agricoltura contadina e liberi il lavoro dei contadini dalla burocratizzazione, poiché esiste un numero imprecisato di persone che praticano un’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare, orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta;Un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più che a fini di arricchimento e profitto; un’agricoltura quasi invisibile per i grandi numeri dell’economia, ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra (soprattutto in montagna e nelle zone economicamente marginali), per mantenere ricca la diversità di paesaggi, piante e animali, per mantenere vivi i saperi, le tecniche e i prodotti locali, per mantenere popolate le campagne e la montagna. Per quest’agricoltura che rischia di scomparire sotto il peso delle documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e igieniche gravose, per ottenere un riconoscimento che la distingua dall’agricoltura imprenditoriale e industriale, per ottenere la rimozione degli ostacoli burocratici e dei pesi fiscali che ostacolano il lavoro dei contadini e la loro permanenza sulla terra.”
Oggi c’è un aspetto molto importante in tutto questo discorso, aspetto costituito dalla possibilità di coniugare insieme il tipo di vita rurale con i controlli igienico-sanitari garantiti dai presidi medici diffusi(chissà ancora per quanto) sul territorio, che un tempo non esistevano o erano meno in grado di controllare spiacevoli o tragici fenomeni. Oggi ci ritroviamo nella condizione di poter tornare indietro progredendo, nella condizione, cioè, di recuperare un modo di vita coniugandolo con il controllo su prodotti e persone propri del nostro tempo. Difficile però che ciò possa avvenire, dato che nel tempo queste forme di agricoltura ed allevamento a gestione familiare sono state progressivamente indebolite dalla costruzione di un apparato legislativo e burocratico volto senza dubbio a favorire la produzione alimentare con mezzi industriali, più facilmente controllabili.