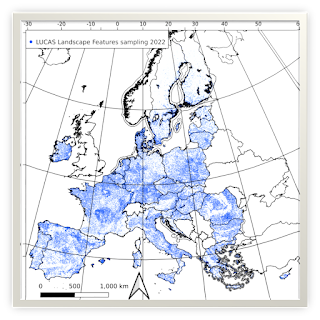L'agricoltura o le agricolture?
La diatriba di questi giorni, può essere tranquillamente ridotta a un conflitto, tra agroindustria super intensiva (nord e europa) con interessi inconfessabili, e l'agricoltura mediterranea, rappresentata da piccole e medie aziende a conduzione familiare, che non ha niente da dividere con la prima.
Dedichiamo questo scritto a una prima riflessione sull’agricoltura contadina, non prima di ribadire dei concetti base:
- L'80% delle risorse europee va a una piccola lobby (20%)di aziende capitaliste.
- L’81% dei Azionisti di maggioranza,(cittadini, contribuenti, consumatori) si dicono preoccupati per l’impatto ambientale dei pesticidi e per il 75% hanno timori rispetto all’impatto dei pesticidi sulla salute umana, come riporta un recente sondaggio della società di analisi di mercato Ipsos.
- Le strategie del Green Deal, come la Strategia Farm to Fork e la Strategia Biodiversità 2030, sono politiche lungimiranti
Seppure oggetto di dibattito internazionale da quasi un secolo, è stata generalmente considerata marginale, ritenendo erroneamente che fosse destinata a scomparire sotto i colpi del processo di modernizzazione. Tuttavia, alcuni elementi qualificanti di questa agricoltura – assunta come inefficiente, improduttiva ed arretrata – costituiscono quella che emerge essere la forma più diffusa, in Italia e nel mondo, di coltivazione: l’agricoltura familiare, ritornata al centro di un intenso dibattito
Molteplici sono stati gli studi specificatamente incentrati sulla persistenza e trasformazione del modo di produrre contadino (Cavazzani 2009; Corrado 2013a, 2013b; Giunta 2014; Pérez-Vittoria 2007; Pieroni, 2008; Van der Ploeg 2006, 2009; Vitale 2013; Sivini 2013a; 2013b). Alla luce di questi studi, ma soprattutto delle dinamiche di mobilitazione e rivendicazione tradotte in proposte politiche, con questa raccolta di contributi si è focalizzata l’attenzione sulle proposte di legge in discussione per comprendere quale sia lo spazio per l’agricoltura contadina in Italia.
L’intervento di Antonio Onorati fa il punto sulle condizioni e le prospettive delle “agricolture” italiane. Da una parte vi è l’industria agroalimentare orientata all’esportazione, sempre meno italiana nonostante l’intenso intervento pubblico, considerata strategica nel rispondere attivamente alla crisi dell’agricoltura ed alla caduta dei consumi, rilanciando il Made in Italy.
Onorati dimostra come all’esiguità del numero di imprese di grandi dimensione capaci di proiettarsi sui mercati globali, superando gli alti costi d’ingresso, corrisponde un dominio sul comparto tanto forte da determinare le politiche pubbliche e esercitare una competizione, a tratti sleale, nei confronti dell’intera agricoltura italiana. Ciò avviene soprattutto a scapito di quelle piccole e medie aziende dell’agroalimentare che, grazie ad un carattere fortemente territoriale, dovrebbero essere, scrive Onorati, “il riferimento assoluto del ‘Made in Italy’”, perché capaci di realizzare prodotti alimentari “eccellenti” ed “inimitabili”. É proprio su queste piccole e medie aziende che si esercita la pressione verso l’abbassamento dei prezzi pagati alla produzione agricola. Dall’altra parte vi è l’agricoltura contadina, articolata su una miriade di piccole e piccolissime imprese agroalimentari. Fondata su una razionalità economica centrata sull’acquisizione di reddito (esclusivo o aggiuntivo) attraverso il lavoro, fortemente radicata nei territori e prevalentemente orientata al mercato locale, ha sviluppato una gestione dell’attività produttiva finalizzata all’autonomia, almeno relativa, dal mercato. Essa rimane, dice Onorati, la struttura su cui continua a poggiare il sistema agroalimentare italiano, nonostante la competizione iniqua con il modello agricolo industriale dominante.

Questo modo di produrre, dunque, lungi dall’essere un problema, rappresenta non solo una risorsa per la sostenibilità dello sviluppo economico italiano ma, più in generale, per la salvaguardia e la valorizzazione delle dimensioni sociali ed ecologiche del sistema agro-alimentare. Queste, ci sembrano, le considerazioni più importanti che hanno portato alle proposte di legge che il parlamento non è stato capace di approvare, per interessi ostili.
L’articolo di Isabella Giunta ne sintetizza i tratti salienti, mostrando come tali proposte, inserendosi nelle pieghe della “svolta verde” della Comunità Europea e dell’attenzione verso l’agricoltura familiare della Fao, siano innanzitutto il risultato di un intenso ed effervescente dibattito sociale, stimolato a livello internazionale dai movimenti contadini, e nei territori da diverse iniziative innovatrici Un dato che ci sembra emergere da questo dibattito, in parte riflesso nelle proposte di legge, riguarda una serie di elementi che specificano l’agricoltura contadina rispetto alla categoria di agricoltura familiare, la quale, come è noto, nella formulazione della Fao si riferisce al controllo ed alla gestione familiare dei più importanti fattori produttivi (terra e lavoro), con esplicito riferimento alle funzioni economiche, ambientali, sociali e culturali (Fao 2014). Ci sembra che l’innovazione apportata dalla riflessione sull’agricoltura contadina sia la qualificazione di queste dimensioni e delle interconnessioni interne che permettono di prospettare un sistema locale di produzione. Così, nella difesa della “dignità del lavoro” e nella richiesta di rendere ad esempio accessibili le terre demaniali, terra e lavoro cessano di essere concepiti come meri fattori produttivi, acquisendo una natura sociale legata, rispettivamente, all’attività lavorativa come spazio di esistenza e fonte di reddito ed alla terra come bene comune o comunque collettivo; da qui, si comprende come l’elemento soggettivo della produzione (il lavoro) possa avere con la terra non esclusivamente un rapporto di proprietà (privata), ma una miriade di relazioni “altre”, che le analisi sulle società non capitalistiche hanno spesso classificato sotto le nozioni di uso e possesso. Nella medesima logica, il rimando all’agroecologia, alla biodiversità e all’economia solidale prospettano la necessità di tener in conto gli effetti sociali ed ecologici sull’ambiente circostante.

Quest’ultimo nesso, e le sfide aperte dal riconoscimento istituzionale del modo di produrre contadino, viene affrontato nell’articolo di Adanella Rossi e Davide Biolghini, con riferimento all’economia solidale quale “particolare cornice di senso” entro cui l’agricoltura contadina multifunzionale interagisce con i contesti socio-ambientali in cui opera. L’enfasi qui è sulla “gestione etica dell’attività” e delle risorse locali, tema intorno al quale si sono sviluppate una molteplicità di pratiche sociali innovative quali, per esempio, i civic food networks.
Evidentemente, una delle sfide cruciali insite nel riconoscimento istituzionale riguarda l’insieme delle condizioni capaci di garantire la riproduzione, secondo la sua specifica razionalità, del modo di produrre contadino. L’articolo di Yvonne Piersante affronta una delle condizioni interne essenziali del processo di riproduzione, ossia il controllo sulle sementi quale diritto collettivo, percorso già intrapreso, anche se molto timidamente, dalla Fao, ma centrale nella proposta Zaccagnini. L’autrice mostra come da questo diritto dipenda il recupero, la conservazione e l’ulteriore sviluppo della biodiversità e, più in generale, della cura del territorio.

L’intervento di Giuseppe Gaudio e Palmerino Trunzo, infine, affronta una questione fondamentale non solo per l’agricoltura contadina, ma in generale per l’agricoltura italiana: il ricambio generazionale, che è trasmissione di conoscenza e saperi produttivi. Non si tratta soltanto di favorire l’accesso alla terra in un momento in cui il “ritorno in agricoltura”, emerso come nuovo fenomeno sociale, è sempre più caratterizzato dall’attenzione all’ambiente, al paesaggio, all’inclusione sociale, alla qualità della vita: “una sfida etica e culturale prima che tecnica”, scrivono i due autori. Si tratta anche di predisporre politiche pubbliche capaci di accompagnare questo processo, prospettando un approccio globale ed integrato. Dal momento che sono proprio le ‘generazioni future’ ad essere continuamente chiamate in causa nei documenti istituzionali sulla sostenibilità, in realtà, esse non possono essere pensate solo come destinatarie: i giovani devono infatti essere parte costitutiva del processo che li riguarda.

L’approvazione di una legge per l’agricoltura contadina, a tutela della sua specificità e che ne valorizzi l’eterogeneità, può essere un importante strumento per costruire spazi di manovra e di agibilità politica, necessari non solo alla resistenza e alla riproduzione delle piccole e medie aziende contadine, ma anche per costruire percorsi di innovazione economica e sociale, per la gestione dei beni comuni, per rispondere ai bisogni sociali, per creare reddito e impiego, per dare riconoscimento e fare emergere pratiche e circuiti economici, oggi in parte informali, finalizzati all’autoconsumo o ai consumi locali. Tale strumento potrebbe essere particolarmente importante per le aree interne o montane (di cui si occupa anche questo numero), in cui l’agricoltura e l’allevamento soffrono spesso ulteriori vincoli, fisico-spaziali, ambientali, socio-demografici ed infrastrutturali. Ma, in generale, si produrrebbe un utile quadro, adatto all’eterogeneità dei soggetti produttivi presenti nelle campagne italiane, entro cui imprimere una nuova dinamicità ai processi di sviluppo rurale, per sperimentare nuove politiche e pratiche per la sovranità alimentare e l’economia solidale, a livello locale e regionale. Certamente, l’approvazione di questa legge sarebbe un importante passo nel cammino verso l’istituzionalizzazione della proposta della sovranità alimentare, promossa dai movimenti sociali a livello internazionale, a cui altri paesi membri e le istituzioni europee potrebbero guardare con interesse, come già sta facendo la Fao. Ciò comporta ripensare la questione agraria come “questione del cibo”, ponendo particolare enfasi sulla necessità di promuovere la riterritorializzazione dei sistemi alimentari, in modo da favorire forme di produzione e consumo ecologicamente e culturalmente appropriate. In questo senso, riconoscere giuridicamente l’esistenza del soggetto produttivo contadino, con le proprie specificità e il connesso diritto a vederle rispettate grazie a misure e strumenti appropriati, significa anche promuoverne il ruolo cruciale svolto nella garanzia dell’accesso al cibo per tutti. Vale la pena, infatti, sottolineare che, secondo stime della Fao (2014), queste agricolture assicurano alla popolazione mondiale attuale, sempre più concentrata nelle aree urbane o metropolitane, più dell’80% degli alimenti consumati su scala globale. Il ricco dibattito a livello internazionale, ospitato in particolare dalla rivista Journal of Peasant Studies, evidenzia alcune criticità: i processi di proletarizzazione, la crescita della popolazione urbanizzata e il conseguente aumento della domanda di cibo nelle città, le differenti possibilità di accesso ad un “cibo di qualità” in funzione dell’appartenenza di classe, le condizioni del lavoro all’interno del sistema agroalimentare, l’organizzazione dei mercati e dei circuiti di distribuzione (si veda in particolare il dibattito tra Henry Bernstein e Philip McMichael). Evidentemente, si tratta di questioni aperte, su cui i movimenti sociali e contadini, insieme alla ricerca, devono continuare ad interrogarsi, sollecitando soluzioni politiche