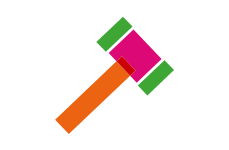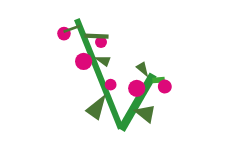Giuliana Cattarossi,
Giovanni Colugnati.
Progetto “Perricone”
Il termine di biodiversità, entrato nel linguaggio comune dopo la
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) di Rio 1992,
è la contrazione di “diversità biologica”,
espressione con la quale si identifica la diversità della vita sulla terra.
Nel suo
significato etimologico biodiversità significa diversità biologica, diversità
degli esseri viventi che popolano la terra e che può essere rilevata sia a
livello molecolare, genetico, sia a livello di specie, ma anche a livello
antropologico, e più in generale, a livello di ecosistemi nei quali si
collocano gli esseri viventi.
La diversità biologica viene classificata a livello genetico, di organismi
viventi e di ecosistema. Secondo
tale definizione, che spazia dalla varianza del patrimonio genetico del singolo
individuo sino all’insieme della varietà biologica di ecosistemi complessi, la
biodiversità tende a coincidere con quello che viene definito il capitale
naturale; nell’analisi degli aspetti ambientali ed economici, è importante,
quindi, precisare, di volta in volta, di quale segmento ci si occupa.
La
biodiversità non va però ridotta semplicemente alla diversità (specificità)
genetica. La diversità del mondo vivente ha molti aspetti: vi è diversità fra
gli ambienti (marino, terrestre, equatoriale, polare, di montagna), fra le
specie e fra gli individui all'interno di una specie ed è il risultato di un
lento e continuo cambiamento che coinvolge la terra nel suo insieme, dalla
geologia al clima agli esseri viventi.
Per
questi motivi essa va studiata sotto diversi profili, biologico, antropologico,
economico, geopolitico, giuridico, ecc. E’ fondamentale anche tenere in
considerazione la componente relazionale della biodiversità, perché essa è
frutto di un processo in cui tutte queste componenti interagiscono e, più in
particolare, scaturisce dalla forte interazione fra profili biochimici ed
antropologici, tanto che si deve parlare propriamente di sistemi bioculturali.
Purtroppo
il dibattito internazionale non concepisce la biodiversità in tale sua
complessità e tende a sminuirne la vastità e la portata. Bisogna considerare
infatti che le stesse risorse genetiche sono al tempo stesso beni di consumo e
beni strumentali alla produzione di altri beni, ma spesso a livello
internazionale vengono considerate solamente come commodities.
Vite selvatica e vite domestica. Le scoperte archeologiche degli ultimi anni e le
potenzialità della biologia molecolare permettono oggi di affrontare il
problema dell’origine dei vitigni sotto una diversa prospettiva, partendo dalla
determinazioni dei rapporti genetici di parentela tra vite selvatica (Vitis vinifera L. ssp. sylvestris) e
vite domestica (Vitis vinifera L. ssp.
sativa).
La vite selvatica cresce
spontaneamente nei corsi d’acqua dei Paesi che si affacciano nel bacino del
Mediterraneo, dal Portogallo al Tagikistan, lungo i maggiori fiumi continentali
dell’Europa occidentale e nell’Africa del Nord (Arnold et al, 1998) ed è una specie dioica con una rara presenza
(5%) di individui ermafroditi.
Dal punto di vista della biologia vegetale, è una liana rampicante che,
allo stato naturale, risale i tronchi degli alberi delle foreste, fino a
raggiungerne la sommità, dove fiorisce producendo poi i propri acini: gli
uccelli apprezzano molto questi frutti, gustosi e facilmente accessibili, e
cibandosene ne diffondono i semi, perpetuandone così la specie.
Quasi certamente i nostri progenitori si arrampicavano pericolosamente
sugli alberi più alti della foresta, solo per riuscire a raccogliere queste
bacche rosse, povere di potere nutritivo, ma spinti da una grande sorpresa
verso una situazione inaspettata. E’ il concetto di “serendipità” alla base dell’ “ipotesi paleolitica” formulata da
McGovern (2003), secondo la quale, alcuni uomini primitivi, attratti dai colori
accattivanti degli acini, raccolsero qualche grappolo d’uva selvatica,
rimanendo sedotti dal suo gusto aspro e zuccherino. Probabilmente ne deposero
diversi grappoli in qualche recipiente (di pelle, legno o pietra) e dopo
qualche giorno, sotto il peso dei grappoli sovrastanti, dagli acini di quelli
più bassi trasudò del succo.
I lieviti della fermentazione, poi, presenti naturalmente sulla buccia
degli acini e liberi nell’aria sotto forma di spore, probabilmente
trasformarono quel succo in una sorta di vino spontaneo e primordiale a basso
tenore alcolico (poco più di un succo semi-fermentato). Una volta mangiati
tutti gli acini, il nostro antenato paleolitico assaggiò più o meno
volontariamente quella bevanda, restando avvinto da una piacevole euforia che
gli instillò un unico pensiero fisso: berne ancora per avvicinarsi a Dio o
cadere negli inferi dell’ebbrezza. Infatti non fu certo l’aroma del vino,
oppure un piacevole retrogusto, ad interessare per primo l’attenzione dei
nostri antichi progenitori ma piuttosto i suoi effetti. In una esistenza quanto
mai ingrata, brutale, pericolosa e soprattutto breve coloro che per primi
provarono gli effetti dell’alcool credettero di avere avuto un anticipo del
paradiso: le ansie scomparvero, i loro timori si attutirono e le idee si
formarono più facilmente, tanto da sentirsi per un breve lasso di tempo
onnipotenti. Nonostante l’ebbrezza ed i suoi effetti le sensazioni finchè
duravano erano troppo belle per resistere alla tentazione di provarle di nuovo
(Johnson, 1991).
Però, in assenza di recipienti idonei, quel “Beaujolais nouveau dell’Età della pietra” (McGovern, 2003) doveva
essere consumato piuttosto rapidamente, prima che si trasformasse in aceto. Ma
le cose cambiarono quando, tra 12 e 10 mila anni fa, le popolazioni umane
divennero stanziali, abbandonando il nomadismo e dando vita a insediamenti
permanenti che sorsero con la nascita dell’agricoltura: questo fenomeno, noto
come la “rivoluzione neolitica”, ebbe come conseguenza l’aumento della densità
di popolazione e la necessità di conservare il cibo più a lungo.